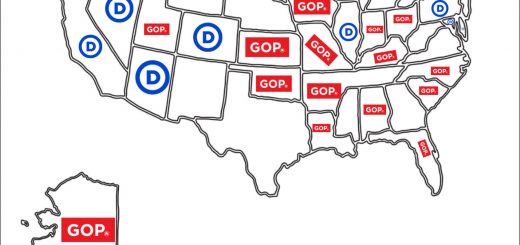La locanda

E le sue diverse interpretazioni
La locanda, luogo popolare che da sempre ha accolto migliaia di persone; bottegai, barboni, vagabondi, soldati, mercenari, attori, cantanti ed anche semplici persone andate lì per rifocillarsi, ha assunto, grazie allo scorrere del tempo e all’affluenza dei diversi personaggi popolani, una grande importanza anche come luogo letterario.

Visto che il termine locanda deriva dal latino “locare” che tradotto significa “allocare, affittare” perché non trasformarla, con l’aiuto di un tocco di fantasia ed un po’ di inchiostro, in una magica atmosfera dove ambientare alcuni fra i racconti e vicende più conosciuti del mondo della letteratura?
È già stato fatto! E pure con successo! Questa ambientazione si potrebbe definire un semplice tocco di classe dell’autore.
Letterariamente la locanda non solo è un luogo facile da raggiungere ma possiamo dire quasi obbligatorio nel percorso di un personaggio viaggiatore ed errante come Don Chisciotte, che vagabondando da giorni, trova un “nido caldo” dove potersi rilassare, rifocillarsi e conoscere nuovi personaggi.
Inoltre, questo luogo di passaggio, non solo spinge uno scrittore a legare tutti i personaggi, o almeno buona parte, in una sola scena od atto, ma consente una facile comparsa e scomparsa dei personaggi stessi.
Tanto che si può creare l’occasione di poter inserire coprotagonisti, aiutanti ed oggetti utili per la vicenda ma si possono riscontrare anche alcuni antagonisti e oppositori.
Questo luogo di possibili incontri, in alcune opere letterarie, assume sembianze di veri e propri alberghi con ristorante. Si possono ricordare così i punti di sosta dei pellegrini di Geoffrey Chauser nel I racconti di Canterbury e l’osteria del romanzo di don Chisciotte, dove, però, l’autore coglie soltanto l’aspetto fiabesco ed intrigante della locanda e la trasforma, con la sua fervida immaginazione, in un castello, cambiando le vesti anche al povero oste, visto da lui come un castellano.
La locanda insomma ha sempre influenzato le scelte degli scrittori, dopotutto faceva parte della vita quotidiana, una vita a volte anche molto intrecciata e complicata, come quella che Alessandro Manzoni ci descrive vicino a “quel ramo del lago Como”. Infatti ne I promessi sposi, Renzo, il futuro sposo nonché protagonista del libro, passerà numerose avventure e sventure nelle locande ed osterie: in una di queste, nonostante pensi di essere al sicuro e di aver lasciato i suoi doveri fuori dalla porta, viene addirittura arrestato.
Insomma queste locande sono una sceneggiatura per qualsiasi possibile storia, verosimile e fantastica ma anche amorosa; ce la ricorda in questo modo il commediografo Carlo Goldoni, che ne La locandiera, uno dei suoi spettacoli di maggior successo, ambienta la sua comicità e il suo modo di intravedere il mondo in una piccola locanda non lontana da Firenze.
Ovviamente la mitica immagine della locanda ci mette poco a passare da un teatro comico ad un teatro lirico, grazie alla rappresentazione del Falstaff, opera lirica di Giuseppe Verdi, che riscopre in quel piccolo mondo le sfumature dell’amore. Infatti il protagonista di quest’opera sarà un donnaiolo ottocentesco di gran classe e seduttore di tutte le donne che entreranno “da quella porta” dice cantando. Che trovandosi in un’osteria apre la scena con in mano una damigiana di vino rosso e con le guance già arrossate.

La locanda però ha avuto anche sfaccettature negative, o almeno alcune di queste, rappresentavano il covo del male. Questo non è dovuto ai numerosi ubriachi che si trovavano lì, ma semplicemente perché in tutte le storie che si rispettino ci deve essere un antagonista, un cattivo che deve avere modo di creare i suoi piani diabolici senza essere disturbato e senza creare sospetti. Dopotutto non c’è miglior modo di confabulare se non trovandosi seduti davanti al camino acceso e con una pinta di birra in mano.
Ed è qui che la locanda più diabolica e spaventosa si mostra, con i suoi cavalieri senza testa, un capitano uncino che suona il pianoforte ed una ostessa con l’aspetto e voce da uomo. È la locanda del film di Shrek, dove il padre di Fiona trova il modo di procurarsi il veleno nel tentativo di uccidere l’amante della figlia.
Abbiamo quindi visto quanto la locanda possa attrarre a sé i diversi personaggi fiabeschi e romanzati, quanto in fondo percorrendo epoche e movimenti culturali è rimasta sempre la stessa: un concentrato di personaggi, di ideologie, di studiosi ma anche di delinquenti e disertori.
Ed ovviamente non poteva mancare, nella sua storia così antica, una sua rappresentazione nell’ambito artistico-raffigurativo. Qui sono ritratte testimonianze di vestiti, piatti caserecci, arredo ed usanze di queste stesse locande ed osterie, grazie all’inventiva di diversi e numerosi pittori. Grazie a loro si possono ritrovare delle vere e proprie piantine di un’osteria compaesana, le loro storie popolari e la loro solita clientela. In questo modo si ricordano pittori come David Teniers il giovane, Pieter Bruegel il vecchio ed alcuni pittori del secolo d’oro olandese, inoltre non possono mancare certo testimonianze di artisti più famosi come quella di Caravaggio, nel dipinto la vocazione di san Matteo.
Insomma, al termine di queste diverse interpretazioni storiche della locanda vi posso dare un solo consiglio: se volete scrivere una storia, ricordatevi di questa potente sceneggiatura ed ambientazione.